Paolo Galletti intervista Marco Martinelli
Marco Martinelli è un drammaturgo e regista del Teatro delle Albe
Questo riscoprirci specie animale vulnerabile, fratello di altre specie e fragile nonostante tecnica e scienze, cosa comporta per chi fa dell’arte la sua ragione di vita? Quali dimensioni oggi deficitarie dell’umano l’arte ci potrebbe aiutare a sviluppare?
Se c’è un linguaggio capace di guardare in faccia la nostra fragilità , è il linguaggio artistico. L’arte, la grande arte, ha sempre saputo che siamo creature ferite, deboli e mortali, si è sempre misurata con l’angoscia della finitudine. Giuseppe Fornari, un filosofo di acutezza straordinaria, ha scritto un bellissimo volume su Leonardo da Vinci dal titolo emblematico: La bellezza e il nulla. Ogni tentativo dell’umanità di creare bellezza è una sfida al nulla che ci circonda, il tentativo di accendere luce nelle tenebre. Ma proprio in questa umile consapevolezza sta la necessità dell’arte ancora oggi: e quando dico “arte” non penso al mercato dell’intrattenimento, all’industria dello spettacolo nella società dello spettacolo, penso a chi, all’interno di linguaggi diversi (teatro, cinema, letteratura, arti visive etc.) fa del proprio paziente scavo quotidiano la sua “ragione di vita”, come hai detto benissimo. Humilitas, dicevano gli antichi, di questo si nutre la “conoscenza”. Mi sembra, al contrario, che la supponenza di certo sapere tecnologico, la sua pretesa di porsi ““ da un paio di secoli – come la nuova religione, l’ideologia vincente, la sua arroganza nel saccheggiare la natura, abbia subito in questa pandemìa un grave colpo. E meritato.
Dal tuo punto di vista quanto è necessaria la conversione ecologica?
Lo è dagli anni Ottanta, da quando abbiamo fondato insieme i Verdi in Italia. Che sia benedetta Greta Thunberg, e con lei tutti gli adolescenti del mondo! Era ora che una nuova generazione si ribellasse all’ideologia dello sviluppo a tutti costi, quando il costo assurdo, il prezzo feroce da pagare, è la distruzione del pianeta. Questi giovani combattono chi vuole rubare loro la speranza del futuro. La conversione ecologica è senza dubbio la prima cosa ragionevole che “l’animale razionale” dovrebbe fare.
E la politica oggi per tornare a svolgere il suo ruolo a quali fonti dovrebbe abbeverarsi?
Della vera politica avremo sempre bisogno. Avremo bisogno di una politica che non sia schiava della finanza e degli interessi dei più forti. Gandhi, e non Machiavelli. E’ chieder troppo? Sì, è chiedere tanto, ma che alternativa abbiamo? Se il mondo ci andasse bene così com’è, non staremmo qui a chiedere, a perdere tempo: giocheremmo in borsa e faremmo la fila davanti ai salotti della gente che conta. Invece no, testardamente continuiamo a sfidare gli orrori delle guerre e della violenza, dell’ingiustizia e degli abusi, testardamente cerchiamo l’azzurro in mezzo alle tenebre. Ce n’erano già tante di epidemie nel nostro paese, prima del coronavirus! Proviamo a farcele sfilare davanti agli occhi: l’aver massacrato la sanità pubblica, così da trovarci totalmente impreparati all’arrivo di questa nuova calamità ; il lasciare la scuola nell’abbandono, che per i padri che scrissero la Costituzione doveva invece essere “il primo bastione di difesa della democrazia”; il non contrastare il potere mafioso e la gran fetta di economia e socialità che comanda, la sua forza di espansione e corruzione; il non investire sulla cultura, perché “con la cultura non si mangia”, e non si butti la croce su chi ha tirato fuori l’infelice espressione, perché di questa opinione ““ al netto dei proclami ipocriti – è l’intera classe politica, visto che, per quel che riguarda i finanziamenti in questo settore, l’Italia è penultima in Europa (ultima invece, “maglia nera”, nei finanziamenti all’educazione); e per tornare alla questione che ci sta tanto a cuore, l’ambiente, possiamo affermare che i politici sentano questo come un tema urgente, come il tema dei temi? Non mi pare. E allora, con pazienza, dobbiamo tornare alle sorgenti del fare politico che, in Grecia, alle origini della prima, imperfetta democrazia conosciuta in Occidente, nacque come riflessione filosofica sulla giustizia: la politica come arte della polis, arte del bene comune, arte della solidarietà . Possiamo sì usare i social e i mezzi che ci fornisce la tecnologia attuale, sapendo però che vanno sostanziati con altro, con studio e riflessioni profonde, con l’immersione nella concretezza dei problemi, in mezzo alle situazioni di disagio, nell’ascolto delle persone. E quest’ultimo aspetto, quello del non stancarsi mai a incontrare veramente le persone le più diverse, per mestieri e classi sociali, è forse la scommessa più grande.
Il rapporto tra generazioni è uno dei nodi problematici più grandi, nell’odierna società massificata: la vostra esperienza, attraverso il teatro?
Mah, quella della nostra compagnia teatrale è un’esperienza un po’ insolita, non saprei dire quanto possa “far testo”. Posso solo raccontarla: insieme a Ermanna, a Luigi Dadina e Marcella Nonni abbiamo fondato le Albe nel 1983, eravamo in quattro all’inizio, una piccola cooperativa, oggi siamo in 40. Tutti a stipendio! E se siamo diventati, nel tempo, una tribù che ha imbarcato al suo interno generazioni diverse, saperi diversi, dagli attori ai tecnici agli organizzatori, forse lo dobbiamo anche al fatto che i fondatori non hanno pensato a “far soldi”, ma hanno sempre condiviso il sapere, l’economia, le responsabilità , con i soci giovanissimi che entravano. Abbiamo tutti lo stesso stipendio “operaio”, per intenderci, e questo “dividere il pane”, come i cristiani delle origini, come certe comunità anarchiche di fine Ottocento, è il terreno più solido che io conosca per far dialogare le generazioni. “Utopia concreta”, diceva Ernst Bloch; “ecologia della mente”, si potrebbe aggiungere ricordando Gregory Bateson.
E cosa mi dici, dal punto di vista del tuo osservatorio, del rapporto tra nord e sud del pianeta?
Beh, sai di toccare un tema che mi sta molto a cuore. Alla fine degli anni Ottanta abbiamo cominciato a lavorare in teatro con tanti artisti africani, dal Senegal al Maghreb, e non abbiamo mai smesso, fino ad arrivare in Kenia in questi ultimi anni, con una Divina Commedia realizzata con 150 bambini e adolescenti di Kibera, il più grande slum di Nairobi. Questa pratica ci è servita tanto! Ci ha portati a guardare il pianeta da prospettive diverse: guardarlo dalla scintillante Fifth Avenue di New York è ben diverso che guardarlo dalle baracche e dalle strade piene di immondizia di Kibera, brulicanti di street children, ragazzi abbandonati o scappati di casa che per resistere ai morsi della fame inalano colla e robaccia. Eppure quanta splendida umanità abbiamo incontrato, nei nostri viaggi in quelle periferie. Papa Francesco nella Laudato sii ha giustamente e autorevolmente intrecciato la questione dell’ecologia a quella della diseguaglianza tra nord e sud del mondo: non ci salteremo fuori, se non terremo ben legate le due sfide.
Per Giacomo Verde
Autori: MARCO MARTINELLI e ERMANNA MONTANARI
Il pensiero, quando pensiamo a Giacomo, corre a quella indimenticabile avventura vissuta insieme quasi trent’anni fa, quando eravamo poco più che trentenni. Le Albe avevano da poco scoperto la Romagna “africana”, avevano appena debuttato con Ruh. Romagna più Africa uguale, lo spettacolo che aveva tenuto a battesimo le Albe afro-romagnole: sulla scena mescolavamo teatro e danza con tre giovani immigrati senegalesi, un inedito per quegli anni, incorniciati in una drammaturgia di Marco che alternava invettive anti-capitalistiche a squarci lirici sulla distruzione della Madre Terra. Era il 1988: e ancora ci muoveva il desiderio di approfondire quel discorso sulla mutazione antropologica cui il nostro paese stava andando incontro, discorso che a tanti in quegli anni sembrava fuori luogo, mentre a noi pareva essere il centro di una mutazione . Ci mettemmo quindi a studiare le favole e le tradizioni dei nostri nuovi amici, griots venuti dall’altra parte del mondo, e fummo incuriositi da alcune storie popolari in cui protagonista era la figura dell’asino, concepita come animale magico: tale concezione rovesciata dell’asinità non ci suonava nuova, perché già nella tradizione occidentale l’animale preso di mira come simbolo di ignoranza era stato venerato come portatore di sapienza. Il titolo del nuovo lavoro arrivò subito: Siamo asini o pedanti?, in cui la concezione dell’asinità e della pedanteria di Giordano Bruno si presentava come uno sberleffo alla Totò. E fu proprio mentre ci immergevamo in quelle profondità , così antiche e così presenti, che conoscemmo Giacomo: la simpatia tra noi scattò immediata. Giacomo, “Giacomino”, come forse non solo noi all’epoca lo chiamavamo, era un fiume in piena di battute e di immediatezza: sia lui che noi non amavamo le pose da artisti, quel rincorrere la visibilità e l’ammirazione a tutti i costi, amavamo invece prendere sul serio le cose sulle quali altri ironizzavano, come la politica, che in quegli anni era passata di moda, e al contempo dileggiare le cose che per altri erano sacre, come i salotti che allora facevano tendenza. Eravamo un po’ alla rovescia: e di Giacomo ci piaceva inoltre la sua versatilità di musicista, il suo suonare diversi strumenti, e quel suo tratto meticcio, nascita in provincia di Napoli e formazione a Empoli, che gli permetteva di recitare indifferentemente in dialetto napoletano e in un toscano materico e popolare, possibilità queste per noi assai preziose, visto che sempre abbiamo chiesto agli attori di lavorare sulla loro lingua madre. Imbarcato quindi in Siamo asini o pedanti?, a Giacomo venne assegnato il ruolo di “Giordano, pastore zampognaro”.
Ci eravamo immaginati un apologo fantastico in cui tre poveri immigrati, Iba, Abib e Khadim, per sbarcare il lunario, erano costretti a vendere il tesoro che si erano portati dal Senegal: Fatima, un’asinella magica e parlante. A volerla comperare un uomo d’affari in giacca, cravatta e pantaloni grigi, cranio rasato in stile mussoliniano, “l’ Uomo in completo”, l’odierna versione del pedante, di chi ha un unico metro per giudicare le cose: il denaro. Che cosa ne farà di Fatima, non si sa: sta di fatto che al tramonto del giorno arriva nel piccolo appartamento dei senegalesi con una borsa piena di soldi sotto il braccio e si mette a contrattare il prezzo. L’affare sembra fatto, ma poi Iba dice che, prima di affidargli l’asinella, Fatima dormirà ancora una volta in casa loro. Solo una notte, l’ultima. Di controvoglia il pedante accetta, costretto però, da una serie di circostanze, a dormire anche lui nella casa degli immigrati. La notte si rivelerà un incubo: quel piccolo appartamento si trasformerà in un circo di apparizioni oniriche, in cui l’uomo diventerà lui la vittima, verrà bendato, gli dipingeranno la faccia di nero, sarà sballottato tra scherzi e secchi d’acqua in faccia, tra Arlecchini africani e asini volanti, fino all’irruzione di tre carabinieri ““evidentemente africani ma con la faccia dipinta di bianco ““ che con modi bruschi e autoritari gli chiederanno il permesso di soggiorno. Al mattino, l’uomo si ritrova solo, e non sa se ha sognato oppure no: sta di fatto che il suo viso è sporco di nero lucido da scarpe e la borsa con i soldi è sparita! A quel punto sulla porta dell’appartamento appare Giordano, lo zampognaro: fino a quel momento lo spettatore lo ha visto attraversare la scena della notte come un fantasma, ballando in tondo, suonando la zampogna, strumento arcaico, asinino. Giordano si lancia in un lungo, surreale monologo sulla Divina Provvidenza, tenendolo vocalmente in un unico interminabile respiro, intarsiando il napoletano all’italiano, passando in rassegna e annunciando al “popolo” presente in platea le “infinite minuzzarìe” che compongono le tragedie di questo mondo: e alla fine, davanti al mercante, impassibile, che vuol sapere cosa ne è stato della sua borsa, lo zampognaro, quasi come se si rendesse conto solo allora della presenza nella casa di quell’Uomo in completo, gli risponde: “Stai tranquillo. Tu”¦ stai tranquillo! Avimm’ pazziat’!”. Abbiamo scherzato: e se ne va, mentre l’eco sinistra di un tuono accompagna la chiusura del sipario.
Quella fu la nostra prima opera insieme. Giacomo era davvero bravissimo a suonare con la voce come con la zampogna. “Surreale zampognaro e interprete dell’esilarante cantata finale, gelida come una doccia fredda, Giacomo Verde, che passa in rassegna statistica, tipo Censis, le “infinite minuzzarìe” della Divina Provvidenza, dando un agghiacciante quadro generale delle cose in questo nostro pazzo, pazzo mondo alle soglie del Duemila”, così scriveva Nico Garrone (1) su “Repubblica”, uno dei critici più attenti e sensibili di quegli anni. Lo spettacolo, nei suoi tratti fantastici, di favola, custodiva in sé le riflessioni che insieme avevamo fatto nei mesi di prova, tanti ragionamenti sulle cause delle migrazioni, sullo sfruttamento del sud del mondo da parte dei potenti della terra, su come un certo progresso in realtà sacrifichi al denaro e alla finanza le vite delle persone, la ricchezza delle diverse culture e degli ecosistemi. Ci trovammo molto bene, noi Albe e Giacomino, e decidemmo di continuare la collaborazione, invitandolo a venire in Senegal per la Ravenna-Dakar, un viaggio di due mesi per, dicevamo, “ricambiare la visita alle Albe nere”. Fu un viaggio di lavoro e di esplorazione: andammo a recitare Siamo asini o pedanti? al Theatre National Daniel Soriano di Dakar e in alcuni villaggi animisti della Casamance, e al tempo stesso volevamo immergerci nella “loro Africa”, un mondo che conoscevamo solo attraverso l’immaginario della letteratura e del cinema, per trarne spunti per quella che sarebbe stata la nuova produzione, già commissionata dal festival di Santarcangelo, allora diretto da Antonio Attisani. Rimanemmo in Senegal dal 1 gennaio 1990 fino alla fine di febbraio: Giacomo arrivò munito della sua telecamera, con l’intento di documentare il viaggio, gli incontri, le scoperte. Fu solo il primo di tanti nostri viaggi, in cui insieme a Mandiaye N’Diaye, la colonna africana delle Albe, ponemmo le basi per la costruzione di una “casa del teatro” a Diol Kadd, il villaggio natale di Mandiaye, guidato dal sogno di “tornare a casa” e mettere a frutto lo strano mestiere che aveva appreso in Italia. Su quel primo passo, Giacomo accumulò ore e ore di girato nei due mesi passati là , nei campus universitari e nei teatri, nella savana e sulle piroghe dei fiumi, dalle quali ricavò una perla di 15 minuti, un breve video che, per lampi veritieri, restituiva appieno il senso di quella avventura. (2)
A Ziguinchor, capoluogo della Casamance, venimmo a sapere di Alinsitowe Diatta. Attorno a uno squisito thè alla menta, ci raccontarono della piccola regina, ribelle ai francesi. Negli anni Quaranta del secolo scorso la società tradizionale dei dìola, nel sud del Senegal, era una società anarchica, senza Stato, priva di autorità centrale: l’unico riferimento erano il re o la regina, nominati democraticamente dai diversi villaggi, il cui ruolo era più quello di sciamani e profeti. Alinsitowe seppe guidare i suoi alla ribellione, spenta poi dai colonialisti nel sangue. Ci dissero che ancora molti dìola la credevano viva, nascosta da qualche parte. Quella figura di donna ci toccò profondamente, vedemmo in lei il simbolo della rivolta contro ogni forma di colonialismo, vecchio e nuovo. Ne parlammo tra noi per giorni, e decidemmo che quello sarebbe stato il tema centrale del prossimo lavoro, Lunga vita all’albero, che debuttò al Festival di Santarcangelo nel luglio di quello stesso 1990.
Note:
1. Nico Garrone, Quell’asinella ci salverà , “la Repubblica”, 5.5.1990, poi in Marco Martinelli, Teatro impuro, Danilo Montanari Editore, Ravenna, 2006, p. 304.
2. Giacomo Verde, Ravenna-Dakar. Il video è visibile sul canale youtube del Teatro delle Albe.

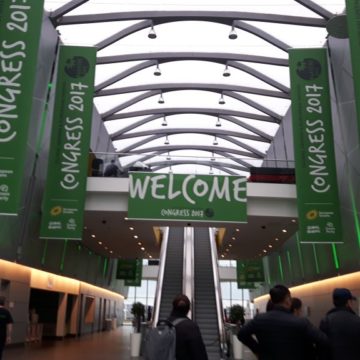

1 commento