L’Emilia-Romagna, obesa e brutta
di Paolo Cagnoli da ‘Terra’ quotidiano ecologista ogni giorno in edicola.
Ogni giorno in Emilia-Romagna è consumata un’area di suolo equivalente ad 11 campi di calcio, con danni rilevanti per la biodiversità , le risorse alimentari, i paesaggi, le tradizioni manutentive. I danni prodotti dal consumo di suolo non sono solo una perdita per l’agricoltura o per il paesaggio, ma colpiscono molte altre funzioni che il suolo svolge: produzione di biomassa, ciclo di nutrienti, riserva di biodiversità , stoccaggio di carbonio.
Alla fine del ‘700 Goethe, durante il suo primo viaggio in Italia, fece una stupenda descrizione della bellezza della Pianura Padana vista dai colli bolognesi; oggi questi paesaggi non possono più reggere il confronto, non solo con il passato, ma neppure con il presente di molte altre regioni d’Italia.
L’Emilia-Romagna ha un metabolismo sovrabbondante, con sprechi e scarti eccessivi; come molte regioni ricche produce impatti ambientali notevoli. L’enorme utilizzo di idrocarburi è solo uno degli squilibri più eclatanti: l’aria qui è troppo inquinata e la colpa principale è dei consumi dei motori, delle caldaie, delle centrali termoelettriche.
L’energia fossile e l’aria inquinata non sono le uniche preoccupazioni ambientali di questa regione: ci sono anche l’inquinamento dell’acqua, il consumo di suolo, il degrado del paesaggio. Questa regione da sempre ha una grande vocazione agricola; ha anche un sistema di pianificazione molto sviluppato, con strumenti urbanistici, territoriali, paesistici, settoriali molto articolati a varia scala.
Però negli ultimi decenni i paesaggi si sono guastati e le superfici agricole utilizzate (SAU) si sono ridotte drasticamente. In questa regione, famosa perché tutti i comuni hanno piani urbanistici approvati, è paradossale che il consumo di suolo sia diventato un problema centrale. I fatti qui dimostrano una cosa: la tutela del suolo non deve essere lasciata in capo solo alla politica locale. I guadagni delle imprese immobiliari cercano di mettere in valore la rendita fondiaria ed i Comuni cercano d’introitare con le concessioni edilizie.
Questi due interessi sono concatenati e vanno in cortocircuito. I Comuni da un lato devono pianificare, per tutelare i suoli, e dall’altro devono far quadrare i bilanci, promuovendo il consumo dei suoli. Così si produce un conflitto d’interessi, che inquina anche la politica; ancor peggio se l’amministrazione eÌ€ in condizioni di necessitaÌ€ economica; ancor peggio in una fase politica disattenta al paesaggio.
Ciò ha prodotto lo svuotamento di molti centri storici, il proliferare di nuovi insediamenti distanti del centro, con sproporzionate domande di servizio. E così via; gli effetti alla lunga sono stati devastanti, soprattutto nella pianura, dando vita ad una “città continua” che ha snaturato il paesaggio emiliano-romagnolo. Dove esistevano paesi ed identità municipali distinte, oggi troviamo un immensa periferia urbana, con un coacervo di interventi privi di disegno organico, sparpagliati in una “conurbazione regionale”, senz’anima.
In Emilia-Romagna, come in tutte le altre regioni europee, si cerca una soluzione alla crisi economica. Si vorrebbe produrre di più a costi contenuti. Il problema è che questa fase politica registra un declino preoccupante delle attenzioni per il paesaggio. La questione del consumo di suolo ancora non s’è intrecciata con le discussioni sul rilancio economico e sul riordino istituzionale. La tutela del paesaggio viaggia su un binario separato e secondario.
Eppure la Convenzione Europea del Paesaggio indicherebbe la strada, per cui la qualità del paesaggio serve ad equilibrare le attività umane con le esigenze della natura; il suolo agricolo, la biodiversità ed il paesaggio dovrebbero essere gestiti come patrimoni capaci di produrre ricchezza e benessere. La lotta contro la cementificazione è in realtà una battaglia per un cambiamento di prospettiva che, a partire dal governo del territorio, deve poi investire la cultura, l’economia, la società , la politica. In Emilia-Romagna ci sarebbe la cultura per avviare questo cambiamento.
L’amministrazione regionale dovrebbe fissare principi di riferimento, con un nuovo piano paesistico, che i comuni dovrebbero applicare, per migliorare la qualità delle aree già urbanizzate, per contenere l’urbanizzazione di suoli vergini, per fare meglio con meno suolo.
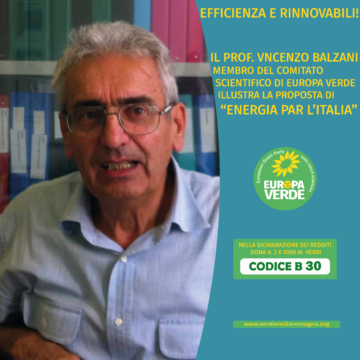


0 commenti